L’ultimo omicidio alla fine del mondo: quando la verità è l’unica bussola
RIFIUTOIDENTITÀLIBERTÀ
9/30/20252 min read
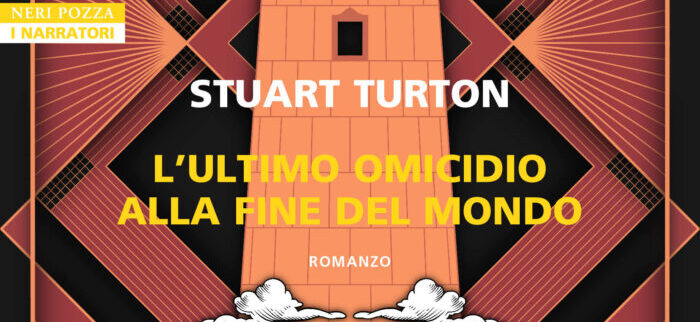
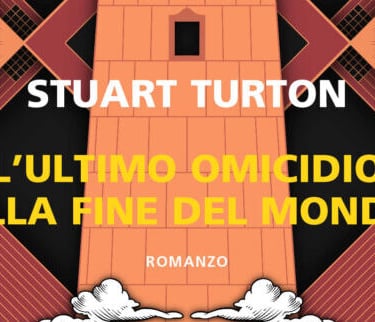
Quest’estate, tra un bagno e l’altro, ho deciso di dedicarmi a una delle mie attività preferite sotto l’ombrellone: leggere un bel giallo. C’è qualcosa di rilassante nell’entrare in una trama misteriosa, lasciarsi trascinare dagli indizi e dimenticare per un po’ la routine quotidiana.
Eppure — come spesso mi succede — mentre leggevo L’ultimo omicidio alla fine del mondo di Stuart Turton, un pensiero psicologico è scappato fuori da solo… ed eccolo qui.
Il romanzo è un giallo travestito da fantascienza (o forse il contrario): ambientato in un mondo post-apocalittico, racconta di una piccola comunità isolata che deve risolvere un omicidio per poter sopravvivere. Se la verità non verrà trovata, tutto finirà.
Quello che mi ha colpito davvero è il modo in cui la storia mette in scena i meccanismi psicologici che emergono quando la verità diventa scomoda. In un contesto dove le certezze sono poche e tutto è sospeso, Turton mostra come oscilliamo tra il desiderio di sapere e la tentazione di chiudere gli occhi, tra la necessità di fidarci e la paura di farlo.
In psicologia, questo spazio intermedio — tra realtà e costruzioni mentali — è fondamentale. Nelle famiglie, nei gruppi, nelle culture, le “verità condivise” fungono spesso da collante identitario. Quando queste verità vacillano, si apre un territorio fragile e potente: quello della ricerca personale, del dubbio, della responsabilità individuale nel ricostruire un senso.
Nel romanzo, i protagonisti non possono più contare su istituzioni, tecnologia o riferimenti esterni: devono fare affidamento al proprio pensiero critico, alla capacità di osservare, di ascoltare e di tollerare l’incertezza.
È un tema molto attuale. Anche oggi ci muoviamo spesso in scenari dove i punti di riferimento vacillano — familiari, politici, sociali — e imparare a farsi domande diventa una competenza vitale.
La comunità del romanzo è al tempo stesso rifugio e prigione: la paura della verità può spingere a proteggere il gruppo con menzogne condivise, ma può anche logorarlo se non si trova il coraggio di guardare le cose in faccia.
E questa riflessione si collega molto a ciò che incontro spesso nel lavoro clinico. Quando lavoro in coterapia con la mia collega, ci capita di trovarci davanti a storie familiari che “non tengono più”: narrazioni condivise che per anni hanno protetto, dato senso, tenuto uniti… ma che a un certo punto diventano gabbie. In quei momenti emerge tutta la sofferenza di chi deve scegliere se continuare a difendere la versione comune della storia, oppure rischiare di rimetterla in gioco per poter crescere. È un passaggio doloroso, ma anche profondamente liberatorio: proprio come nella comunità del romanzo, è lì che si decide se restare imprigionati o aprire la strada a una verità nuova.
Per me, L’ultimo omicidio alla fine del mondo è più di un giallo: è un racconto su quanto siamo disposti a mettere in discussione le nostre certezze per vivere in modo autentico, come individui e come comunità.
