Hunger Games: quando il trauma ti impedisce di fidarti di nuovo
RABBIASOLITUDINEIDENTITÀ
7/23/20252 min read
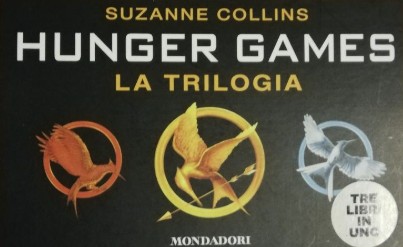
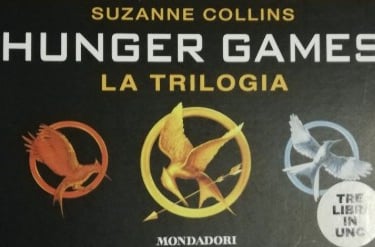
Quando ho letto Hunger Games per la prima volta, ho avuto la sensazione di trovarmi davanti non solo a una distopia politica, ma a una lunga, dolorosa metafora del trauma.
Katniss Everdeen non è un’eroina classica. È una sopravvissuta. E sopravvivere, nella sua storia, non significa solo restare vivi, ma tenere insieme pezzi di sé in un sistema che cerca costantemente di usarli.
I giochi non finiscono quando lei esce dall’arena.
L’arena si sposta.
Diventa mediatica, politica, familiare. Diventa interna.
In molti pazienti vedo qualcosa di simile: dopo aver superato la “battaglia” (una relazione tossica, una malattia, un lutto, un periodo di vita schiacciante), ci si aspetta che siano “guariti”. Ma dentro resta una guerra a bassa intensità, fatta di ipervigilanza, senso di colpa per essere sopravvissuti, incapacità di fidarsi di nuovo.
Katniss, anche quando non è più costretta a combattere, non riesce a rilassarsi. Dorme male. Ha flashback. È sospettosa anche con chi le vuole bene. Perde confini tra il ruolo pubblico e il sé autentico.
Non è debole. È traumatizzata. E il trauma non si vede, spesso, perché funziona. Perché è adattivo.
La cosa che più mi ha colpito è la trasformazione silenziosa del suo volto: da ragazza invisibile a simbolo della rivolta, passando per uno sguardo che non può permettersi di mostrarsi fragile.
Ma la fragilità, quella vera, arriva dopo. Quando il rumore finisce.
Quando tutto è apparentemente “risolto”.
E lì comincia il vero lavoro — anche in terapia.
Togliere la corazza. Riconoscere quanto ha fatto male. Ammettere che si è agito per proteggersi, e le nostre scelte non sono state vere scelte.
Katniss non riesce a tornare davvero a vivere.
Non si fida. Non si lascia andare. È come se l’arena fosse rimasta dentro di lei — anche fuori dal gioco.
Succede anche nella vita reale. Quando viviamo situazioni di pericolo, trascuratezza emotiva, o manipolazione affettiva, il corpo impara a difendersi, ma la mente... e il cuore... imparano a chiudersi.
"Conservo il controllo. Non mi espongo. Valuto tutto e tutti. Anche chi potrebbe volermi bene."
La relazione con Peeta è esemplare: lui la ama, è presente, è stato anche lui traumatizzato — ma lei lo tiene a distanza. Non è solo paura dell’intimità: è perdita di fiducia nella possibilità che l’amore non sia uno strumento, ma una trappola, una nuova arena.
Katniss ha imparato a sopravvivere adattandosi, camuffandosi, diventando l’immagine che serviva. Lo fa per salvare la sorella. Poi per difendere i più deboli. Poi per diventare simbolo.
Ma sotto a tutto questo c’è una domanda silenziosa: posso fidarmi senza perdermi di nuovo?
E la risposta non arriva subito. È lenta. Fatta di esitazioni, crolli, silenzi.
Fatta di relazioni in cui imparare a non essere sempre in allerta, a non leggere ogni gesto come un potenziale inganno, a scegliere di abbassare le armi.
Uscire dall’arena, nella vita come nei libri, non significa solo salvarsi. Significa riuscire, piano piano, a credere che qualcuno possa vedere chi sei — e restare con noi, senza abbandonarci di nuovo.
